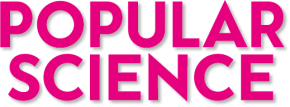A vent’anni dalla sua approvazione, la legge 219 resta una pietra miliare nella storia del sistema trasfusionale italiano. Lo conferma Giuliano Grazzini, primo direttore del Centro Nazionale Sangue (Cns), istituito proprio da quella norma che ha ridisegnato, in chiave moderna, l’intero assetto della rete trasfusionale. “La legge 219 è stata indubbiamente molto importante per il sistema sangue italiano”, esordisce Grazzini, ricordando come il nuovo quadro normativo sia nato “dalla sintesi di una complessa serie di esigenze e proposte provenienti dal mondo dei servizi trasfusionali, dai professionisti e dalle associazioni di volontariato”. Un percorso lungo, quello della legge, ma approdato a un risultato condiviso: “Fu approvata in forma bipartisan e ancora oggi risulta molto ben incardinata nei principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità del nostro Servizio sanitario nazionale”.
I principi etici: gratuità, volontarietà e responsabilità Uno degli aspetti più innovativi della legge 219 è stata la riaffermazione netta dei valori fondanti del sistema sangue: “Ha introdotto una forte riaffermazione dei principi etici fondanti con l’acquisizione definitiva del concetto di donazione volontaria, non remunerata, periodica e responsabile”, sottolinea Grazzini. La norma ha posto le basi per una gestione “non lucrativa delle attività trasfusionali”, riconoscendo la gratuità del sangue e dei suoi prodotti e ribadendo “il carattere pubblico di tutte le attività trasfusionali”. Accanto ai valori, c’è anche una profonda riforma organizzativa: “Per la prima volta sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza delle attività trasfusionali, insieme a novità fondamentali in tema di programmazione, accreditamento, autorizzazioni, qualità e sicurezza”.
Dalla frammentazione alla rete nazionale La legge 219 ha segnato il passaggio da un sistema frammentato a una vera rete integrata. “Siamo passati da un insieme di strutture e soggetti che operavano in modo isolato – i singoli servizi trasfusionali, le regioni, le associazioni – alla costituzione di una rete coordinata a livello regionale e nazionale”, spiega Grazzini.
Un cambiamento “epocale”, come lo definisce lui stesso: “Un assetto improntato alla condivisione, alla collaborazione e alla crescita delle singole componenti e della rete nel suo insieme”. In questo nuovo contesto, il Centro Nazionale Sangue ha assunto un ruolo chiave: “Svolge un ruolo cardine come punto di riferimento, collettore di esigenze, proposte e criticità, ma anche come nodo fondamentale della rete dei Paesi dell’Unione Europea e organo tecnico del ministero della Salute”.
Associazioni di donatori: una presenza strategica Un altro elemento di svolta introdotto dalla legge 219 riguarda il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle associazioni e federazioni di donatori di sangue. “Le associazioni sono presenti a livello strategico in tutti gli organi di governo e partecipazione del sistema, dal ministero della Salute al Cns, fino ai Centri Regionali Sangue e ai Comitati ospedalieri”, ricorda Grazzini. Un protagonismo che non è solo istituzionale, ma anche operativo: “Su oltre tre milioni di donazioni annue, più di un milione avviene presso unità di raccolta gestite dalle associazioni di volontariato, sotto la supervisione tecnica dei servizi trasfusionali”.
L’adeguamento agli standard europei L’altro grande capitolo di trasformazione è quello dell’armonizzazione con la normativa europea. La legge 219, approvata nel 2005, fu seguita dall’emanazione di tre direttive europee nel 2007 che ridefinirono radicalmente i requisiti di qualità e sicurezza del settore. “È stato un percorso faticoso e impegnativo – ricorda – per portare tutte le attività trasfusionali a essere conformi sia ai requisiti nazionali che europei, includendo anche quelli propri del mondo del farmaco”.
Il primo traguardo fu raggiunto nel luglio 2015, ma il percorso è tuttora in evoluzione: “È un cammino sempre attivo, chiamato a confrontarsi con nuove sfide, come l’attuazione del nuovo Regolamento europeo sulle sostanze di origine umana, che dovrà entrare in vigore entro il 2026-2027”.
Apertura all’Europa e autosufficienza nazionale L’Italia ha progressivamente assunto un ruolo di primo piano a livello europeo. “Il sistema sangue italiano ha rafforzato la propria partecipazione negli organismi europei e si è affermato come leader in numerosi progetti internazionali”, sottolinea l’ex direttore del Cns.
Ma l’altro grande risultato è stato il consolidamento del principio di autosufficienza: “È diventato un obiettivo di sistema, un patrimonio collettivo nazionale e regionale, non più locale o ospedaliero”. Un concetto tradotto in pratica attraverso strumenti come il Sistema informativo dei servizi trasfusionali e la programmazione annuale per l’autosufficienza, avviata nel 2008. “Grazie alla collaborazione di tutti gli attori del sistema – ricorda Grazzini – nel maggio 2008 pubblicammo in Gazzetta Ufficiale il primo programma annuale di autosufficienza, poi aggiornato ogni anno”.
La forza di una rete coesa e solidale Il modello italiano si distingue anche per la capacità di coordinamento e monitoraggio costante: “Sono stati istituiti incontri periodici di confronto e verifica tra tutti i soggetti della rete, oltre a meeting scientifici e regolatori promossi dal Cns”, spiega Grazzini. Tutto questo ha generato “un grande passo avanti per la coesione del sistema”, culminato nell’apertura del mercato europeo anche alla produzione di medicinali derivati dal plasma, parte integrante della strategia di autosufficienza nazionale.
Un modello di successo tra pubblico e volontariato “Il modello italiano del sistema sangue rappresenta un successo storico”, conclude Grazzini. Una sinergia che poggia su due pilastri: un’infrastruttura pubblica “efficace, efficiente e qualitativamente controllata” e “quel grande capitale sociale generato dalle associazioni di volontariato”. Un esempio dice, “di come la sanità pubblica e il terzo settore possano collaborare per il benessere della collettività”.
E.M.